Il Tribunale di Brescia, con propria sentenza del 3 novembre 2017, ha dichiarato legittimo il recesso intimato ad una lavoratrice per mancato superamento del periodo di prova. In particolare la lavoratrice lamentava la nullità del patto di prova accluso al contratto di lavoro per indeterminatezza delle mansioni assegnate, essendo stata assunta come “Commodity Manager” ed inquadrata nella 6^ Categoria del CCNL dell’Industria Metalmeccanica Privata. Il Tribunale ha, invece, ritenuto questa indicazione più che sufficiente, richiamando sul punto l’orientamento della Suprema Corte secondo cui “specie quanto trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, le mansioni non devono essere necessariamente indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula utilizzata nel documento contrattuale, siano determinabili”. Come se non bastasse il Tribunale ha evidenziato che il significato dell’espressione “Commodity Manager” era ben noto alla lavoratrice, avendo, tra le altre, la stessa fornito alla società un curriculum vitae in cui dichiarava di aver ricoperto proprio tale ruolo presso altra società. Non solo. La lavoratrice eccepiva pure la mancata corrispondenza tra le mansioni assegnate e quelle stabilite in contratto. Eccezione anch’essa rigettata dal Tribunale sull’assunto che, stando alla produzione documentale in atti, la lavoratrice, sin dall’inizio della sua attività alle dipendenze della convenuta, era stata adibita a mansioni perfettamente in linea con quelle concordate. Come se non bastasse la lavoratrice lamentava l’impossibilità della prova a causa della sua esiguità, essendo rimasta assente prima per ferie poi per malattia ed infine in astensione anticipata per gravidanza. Il Tribunale nel respingere anche questa doglianza, osservava che la lavoratrice – pur escludendo dal computo dei giorni effettivamente lavorati i predetti periodi – aveva lavorato per i 2/3 del periodo di prova originariamente previsto e, quindi, per un periodo sufficiente a consentire al datore di lavoro di apprezzare la sua idoneità a ricoprire il ruolo richiesto. Con riferimento, infine, alle motivazioni addotte dalla società a fondamento del recesso e contestate dalla lavoratrice, il Tribunale, dopo aver osservato che normalmente il recesso dal patto di prova non necessita alcuna motivazione da parte del datore di lavoro, ha richiamato una sentenza della Corte costituzionale secondo al quale “il datore di lavoro che risolve il rapporto di lavoro in prova con una lavoratrice di cui, all’atto del recesso, gli è noto lo stato di gravidanza, deve spiegare motivamente le ragioni che giustificano il giudizio negativo circa l’esito dell’esperimento, in guisa da consentire alla controparte di individuare i temi della prova contraria e al giudice di svolgere un opportuno sindacato di merito sui reali motivi del recesso, al fine di escludere con ragionevole certezza che esso sia stato determinato dalla condizione di donna incinta”. Ebbene, secondo il Tribunale, parte convenuta aveva adempiuto al proprio onere specificando nella relativa comunicazione tutte le motivazioni che avevano portato a decidere per l’interruzione del rapporto di lavoro mentre parte ricorrente non era riuscita a dimostrare l’asserita discriminazione subita. All’esito del giudizio, il Tribunale ha, quindi, respinto il ricorso della lavoratrice, condannandola al pagamento delle spese di lite, quantificate in Euro 2.500, oltre accessori di legge.

La corretta gestione dei controlli datoriali che possono essere attuati da un datore di lavoro è un tema da sempre sensibile per le aziende oggi reso ancor più rilevante dalla diffusione di tecnologie e strumenti sempre più evoluti. Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno ribadito alcuni principi fondamentali sulla legittimità delle verifiche datoriali, sia ....
Leggi di più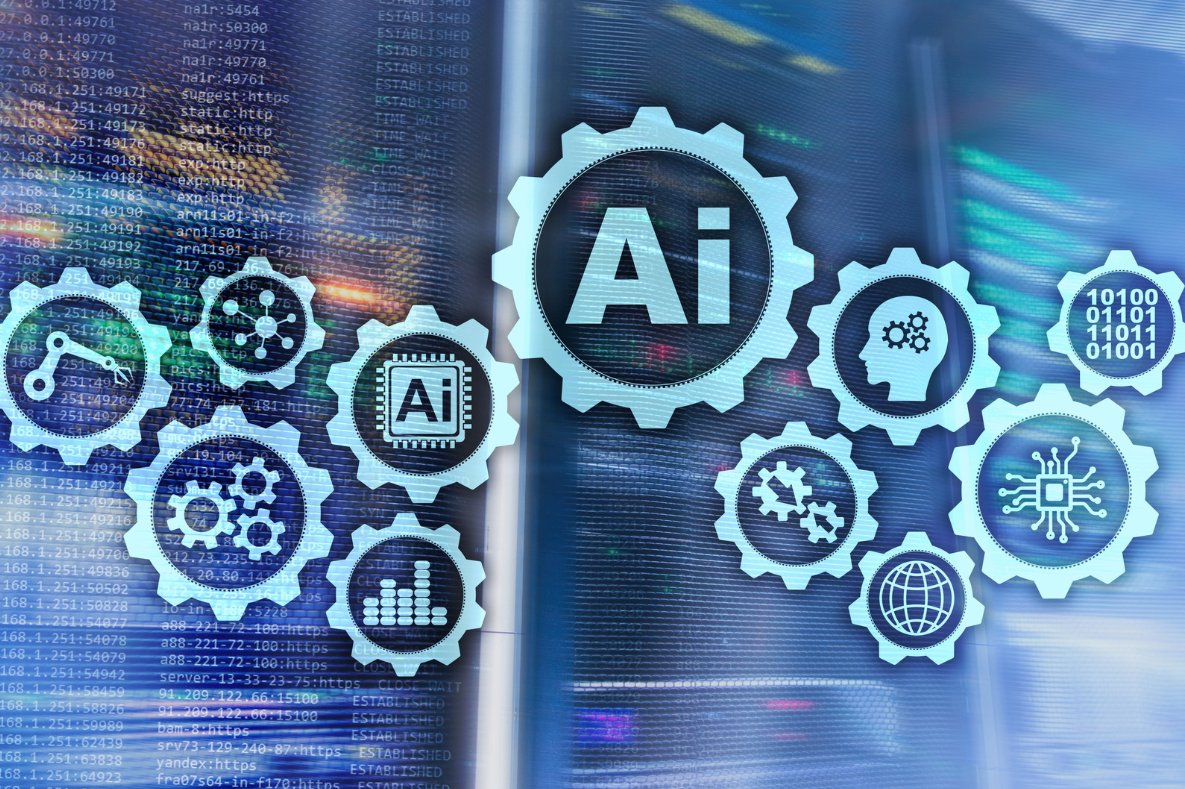
L’intelligenza artificiale in azienda comporta rischi relativi alla sicurezza dei dati e alla protezione del know-how. Le organizzazioni necessitano di policy adeguate per garantire un utilizzo etico e conforme alla normativa Quando un dipendente ricorre a sistemi di intelligenza artificiale – spesso generativa – per svolgere le proprie attività lavorative potrebbe, in maniera più o meno consapevole, condividere ....
Leggi di più
In occasione del nostro ultimo Team Meeting tra i vari argomenti, abbiamo presentato una relazione sull’ultima Direttiva UE in materia di parità retributiva di genere. Normativa italiana in materia di parità retributiva «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. » D.lgs. 198/2006 (come modificato dalla ....
Leggi di più
Con un Provvedimento del 16 gennaio 2025, reso noto tramite il servizio di newsletter istituzionale del 21 marzo 2025, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’azienda di autotrasporti per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità che ....
Leggi di più
