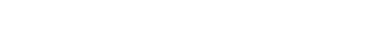L’intelligenza artificiale in azienda comporta rischi relativi alla sicurezza dei dati e alla protezione del know-how. Le organizzazioni necessitano di policy adeguate per garantire un utilizzo etico e conforme alla normativa
Quando un dipendente ricorre a sistemi di intelligenza artificiale – spesso generativa – per svolgere le proprie attività lavorative potrebbe, in maniera più o meno consapevole, condividere con soggetti esterni, e quindi non autorizzati, know-how aziendale e informazioni personali.
Intelligenza artificiale in azienda: definizione e diffusione
Vale, innanzitutto, la pena precisare che l’Intelligenza Artificiale generativa è una tipologia di tecnologia che impara dai contenuti esistenti per generarne di nuovi in base alle specifiche richieste del suo interlocutore (umano).
Negli ultimi anni, l’I.A. generativa è entrata nel quotidiano e il mondo del lavoro non ne è stato esente. Accade infatti con sempre maggior frequenza che i lavoratori utilizzino tali tecnologie per portare a termine le proprie attività e nel farlo immettano nei sistemi informazioni aziendali, anche sensibili, know-how aziendale ovvero dati personali e particolari. Spesso le aziende non sono informate o non sono consapevoli di tali pratiche e rischiano di essere esposte a importanti rischi – anche dal punto di vista della cybersicurezza – senza neppure esserne coscienti.
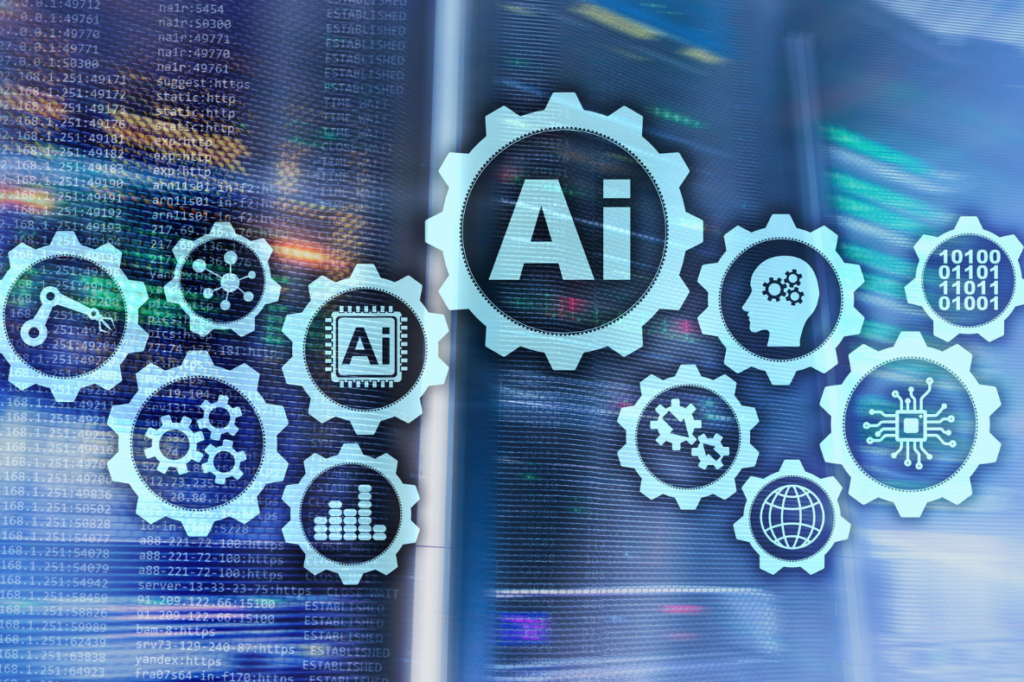
I rischi dell’intelligenza artificiale in azienda, spiegati dall’IA
Nel tentativo di rispondere a questo quesito, abbiamo voluto interpellare una delle parti direttamente coinvolte. Di seguito, per punti, i principali red flag legati all’adozione di I.A. generativa che lei stessa ci ha segnalato.
Secondo l’I.A., acconsentire a che i lavoratori utilizzino queste tecnologie potrebbe comportare per una società:
- problematiche connesse alla governance e alla gestione della sicurezza informatica;
- violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- commissione di comportamenti discriminatori derivanti dai pregiudizi (bias) contenuti nei dati con cui è stata addestrata;
- eccessiva dipendenza dei lavoratori all’intelligenza artificiale che, nei casi più gravi, potrebbe causare un pericolo di riduzione delle capacità decisionali e critiche tipiche dell’essere umano.
Tutti spunti interessanti ai quali non si può non aggiungere anche il rischio di divulgazione di know-how aziendale e quindi di dispersione di informazioni sensibili per una azienda.
Protezione dell’azienda nell’era dell’intelligenza artificiale
Da queste brevi considerazioni, sorge spontaneo domandarsi come una società possa quindi proteggersi da tutti i rischi connessi ad un uso generalizzato, diffuso e non controllato dell’I.A. generativa da parte dei lavoratori.
In uno scenario che può intimorire e creare scetticismo, certamente la soluzione non può essere quella di impedire l’utilizzo di tali tecnologie che, al contrario, rappresentano sempre più un elemento per rimanere competitivi e contribuiscono allo sviluppo dell’azienda ma anche alla crescita delle sue risorse (umane).
Fondamentale diventa quindi imparare a farne un uso etico e consapevole.
Linee guida per l’intelligenza artificiale in azienda
- È fondamentale non permettere che i dipendenti ricorrano all’I.A. senza regolamentarne internamente l’utilizzo e fornire loro specifici training, linee guida e best practices. Investire in formazione, in sistemi di sicurezza solidi e in politiche di gestione del cambiamento per garantire che l’adozione dell’I.A. porti vantaggi reali senza però compromettere la sicurezza, l’integrità o la cultura aziendale è una esigenza di primaria importanza.
Continua a leggere la versione integrale pubblicata su Agenda Digitale.